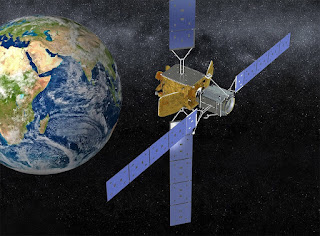L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite è un grande piano globale che punta a rendere il mondo più giusto, sostenibile e vivibile per tutti entro il 2030. Comprende 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), che spaziano dall’eliminazione della povertà alla lotta ai cambiamenti climatici, dal diritto all’istruzione al lavoro dignitoso. Ma a che punto siamo oggi?
I dati più recenti dicono che la strada è in salita: solo il 17% dei target è davvero “sulla buona strada” per essere raggiunto, mentre la maggior parte avanza troppo lentamente e diversi obiettivi stanno addirittura peggiorando. Questo significa che il mondo, al momento, è in ritardo rispetto agli impegni presi.
Tra gli obiettivi più critici troviamo:
SDG 2 – Fame zero: dopo la pandemia, il numero di persone che soffrono la fame è tornato a crescere, arrivando a oltre 700 milioni. Anche la malnutrizione infantile rimane un problema enorme.
SDG 4 – Istruzione di qualità: sebbene più ragazzi riescano a completare la scuola, il livello di competenze in lettura e matematica sta calando, complice la pandemia ma anche problemi strutturali, come la mancanza di insegnanti qualificati in molte aree del mondo.
SDG 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica: il mercato del lavoro è fragile, la disoccupazione giovanile resta alta e milioni di persone lavorano ancora in condizioni precarie o informali.
SDG 12 – Consumo e produzione responsabili: i Paesi ricchi sprecano enormi quantità di cibo ed energia, contribuendo a inquinamento, perdita di biodiversità e cambiamenti climatici.
Non mancano però anche notizie positive. Alcuni progressi significativi ci sono stati: la mortalità infantile è diminuita, sempre più persone hanno accesso ad acqua pulita e servizi igienici, le energie rinnovabili stanno crescendo e in diversi Paesi gli investimenti in ricerca e innovazione stanno aumentando.
Guardando alle classifiche internazionali, i Paesi del Nord Europa – come Finlandia, Svezia e Danimarca – sono tra i più avanzati nel raggiungere gli SDG, grazie a sistemi sociali solidi, politiche ambientali coraggiose e un alto livello di benessere diffuso. Al contrario, molti Paesi dell’Africa sub-sahariana, ma anche Stati segnati da guerre e crisi come Afghanistan e Yemen, faticano a garantire diritti fondamentali come il cibo, la salute e l’istruzione.
Il quadro generale, dunque, è fatto di luci e ombre. Se da un lato ci sono esempi positivi e progressi incoraggianti, dall’altro il tempo stringe e il 2030 si avvicina. Per recuperare il ritardo serviranno scelte coraggiose: trasformare i sistemi alimentari ed energetici, ridurre gli sprechi, investire in istruzione e lavoro dignitoso, e rafforzare la cooperazione tra Paesi.
L’Agenda 2030 non è solo un obiettivo dei governi, ma riguarda tutti noi: ciascuno, nel proprio piccolo, può contribuire a un futuro più sostenibile e giusto.





.png)